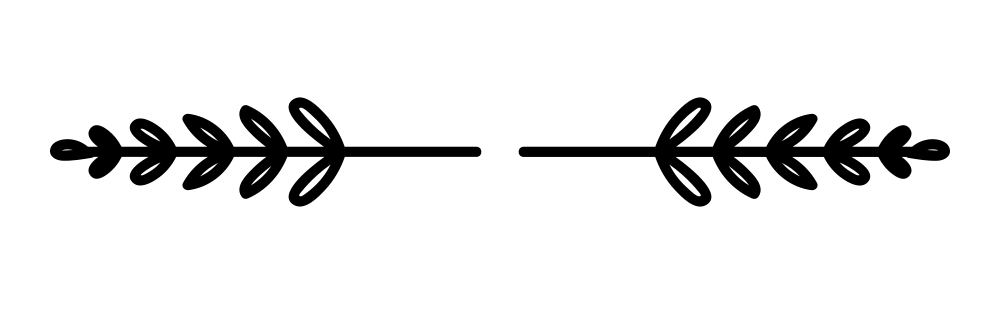Non è la prima volta che mi lascio incuriosire da un romanzo per i suoi riferimenti alla Sardegna.
Da esule involontaria, sento ancora un forte attaccamento verso la mia Terra e spesso cerco di attenuare questa malinconia quasi perenne rifugiandomi in libri e articoli che me la mostrano sotto una nuova ottica, regalandomi visuali che, da nativa, avevo sempre tralasciato e dato per scontate. Non è un segreto, d’altronde, dato che qui sul blog ormai da anni va avanti la rubrica Voci dalla Sardegna, uno specchietto in costante aggiornamento che mi permette di portarvi con me alla scoperta delle meraviglie letterarie della mia Terra.
Così, sono rimasta subito colpita quando nel comunicato stampa della Newton Compton Editori i miei occhi si sono posati sulla quarta di copertina de La lettera dell’amore perduto di Debbie Rix e sui riferimenti all’isola di Sant’Antioco, quel piccolo fazzoletto di terra indicibilmente affascinante che sorge a sud-ovest della Sardegna. Non era la prima volta che leggevo della caratteristica penisola (solo di recente è stata la nostra Cristina Caboni a portarci in viaggio verso Sant’Antioco), ma era sicuramente la prima volta che a trasportarmi lì era un’autrice straniera, una turista rimasta incantata da questa terra al punto di scegliere di ambientarci in parte il suo nuovo romanzo.
Non ho atteso dunque che una manciata di secondi prima di richiedere questo romanzo e lasciarmi coinvolgere nelle vicende di Sophie, dottoranda in archeologia specializzata in sepolture romane, e della sua nonna Rachel, ungherese di origine, londinese per buona parte della sua vita, e legata a stretto nodo con quella piccola isoletta magica.
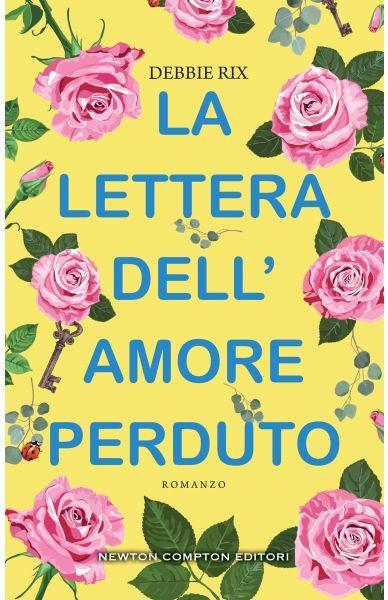
Il viaggio al loro fianco è stato particolare, e benché lo svolgimento delle due storie sia stato abbastanza coinvolgente da spronarmi a voltare una pagina dopo l’altra in tempi brevi, si anche rivelato deludente sotto diversi importanti aspetti.
Strano a dirsi, la delusione non è arrivata sull’aspetto della Sardegna, il più delicato essendo io così legata alla narrazione dell’isola. Questo lato, infatti, mi ha sorpresa più ti quanto mi aspettassi. Lo sguardo che Debbie Rix riserva all’isola è colmo di tenerezza e amore. Si nota quanto sia rimasta legata a Sant’Antioco e alle sue tradizioni, specialmente quelle riguardanti il bisso e la sua tessitura, e sotto questo punto di vista non ho avuto alcunché di cui lamentarmi. La lettera dell’amore perduto è anche una dedica appassionata alla mia terra ed è stato davvero piacevole vivere quei luoghi così familiari con le sensazioni di chi li ha amati da lontano per tanto tempo.
Il vero problema, nel mio caso, è sorto davanti allo stile scelto da Debbie Rix: nell’alternarsi scandito di momenti del passato di Rachel e fasi del presente di Sophie, la Rix ha voluto raccontare la sua storia con una voce esterna e distante, un narratore dedito più alla descrizione meccanica che all’immersione emotiva. Così, molte scene si sono risolte in una mera sequenza di eventi, una successione di movimenti sulle pagine che hanno ottenuto l’effetto di mantenermi lontana dall’essenza di Sophie e Rachel per quasi tutto il romanzo.
La Rix ha fatto un uso massivo e spesso opprimente del Tell a discapito dello Show, come verrebbe probabilmente descritto da chi ha più competenza ed esperienza di me. Ha scelto un narrare più che un mostrare che tiene il lettore sempre a distanza, fuori dalla sfera emotiva e psicologica dei personaggi. Gli eventi, all’interno della scena, si sono infatti susseguiti in modo così rapido che è stato quasi difficile fissarli nella mente. Non ci sono state pause di rilassamento, non c’è stato spazio per l’approfondimento di questa o quella sensazione, ma l’intero romanzo è apparso quasi come una corsa frenetica verso la fine.
Fluido dunque, ma forse fin troppo.
A trasmettermi un ulteriore senso di spaesamento in lettura, si è aggiunta la sensazione che molti degli eventi narrati nel romanzo accadessero solo in funzione della narrazione stessa, in modo forzato e meccanico. Non un’evoluzione delle protagoniste e delle loro storie, dunque, ma piuttosto uno scandire prefissato di avvenimenti necessari all’autrice per arrivare dal punto di partenza a quello di fine.
Dialoghi poco realistici ma ad alto contenuto informativo, scelte poco sensate ma utili per andare avanti e, sullo sfondo, un risvolto storico e artistico rappresentato dal bisso e dalle tombe romane che però non ha mai trovato un compimento, risultando più una costante dell’equazione dei personaggi che una vera e propria linea narrativa solida a sé stante.
Per finire con un lato più personale, alla difficoltà di trovare un mio spazio nella narrazione si è aggiunta una viscerale e purtroppo incontrollabile insofferenza verso un messaggio che percepivo filtrare in ogni pensiero e dialogo della protagonista più giovane. Sophie, la nostra dottoranda, ha infatti un chiodo fisso che ci accompagna per tutta la narrazione: il desiderio quasi ossessivo di diventare mamma, un aspetto che nel mio caso avrebbe potuto spingermi a legare con questo personaggio ma che, nell’applicazione, ha solo contribuito a farmi sentire ancora più distante.
Con la scusa di questo desiderio, infatti, la Rix sembra quasi voler giustificare un pensiero e una serie di azioni che personalmente trovo al limite dell’assurdo.
Un annullamento della personalità della donna in funzione del suo desiderio di essere madre, ad esempio, un’ossessione che la spinge ad accantonare tutto il resto, compagno compreso, pur di arrivare a quell’obiettivo. E un continuo tormento e accanimento della protagonista ai danni di un compagno che non condivide questa viscerale ossessione, che si traduce non solo in liti furibonde e pianti isterici verso di lui e verso ogni parente che non comprenda il suo bisogno, ma addirittura in un inneggiare al diritto della donna di ottenere un figlio a ogni costo, anche ingannando il proprio partner e arrivando alla soluzione estrema di bucare il preservativo a sua insaputa (soluzione che viene raccontata alla protagonista dalla madre in modo naturale e divertito, quasi si fosse trattato di uno scherzo di poco conto e non di un grave abuso della propria posizione di donna e compagna).
Un messaggio, dunque, che spesso sfiora gli eccessi di quell’emisfero che si dichiara femminista, ma che del femminismo non pare aver ancora colto il senso più profondo: il diritto di essere donna accanto all’uomo e non sopra di lui. Il diritto di decidere del proprio corpo e non anche di quello del proprio compagno. E soprattutto il diritto di sentire il bisogno di concepire un figlio, ma senza imporre questo bisogno nell’altro.